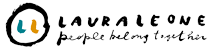III. Il coachee: Tempo e Cambiamento
Considerato anche in un senso più ampio, il tempo, nel Coaching, è un elemento fondamentale del cambiamento. Anche nel kairos è contenuto il cambiamento, ma in un’accezione più ristretta; in questo articolo si vuole fare riferimento al cambiamento (o miglioramento, che è anch’esso un cambiamento) come scopo ultimo di un percorso di Coaching. Da un certo punto di vista, assolutamente condivisibile, è possibile affermare che un non cambiamento non può esistere, e cioè che è impossibile, per l’esistenza umana, non subire mutazioni. Pensiamo invece, per un attimo, che non cambiare sia possibile. Per fare ciò, occorrerà mettere momentaneamente da parte – come per un esperimento scientifico – l’aspetto biologico, materiale, dell’esistenza; vedremo come questo tornerà in gioco proprio per sostenere l’esistenza del non cambiamento.
Il presupposto – per me fondamentale – da cui partire per esprimere il concetto di non cambiamento è quello del legame tra cambiamento e auto-consapevolezza: un vero cambiamento è solo un cambiamento consapevole, perché solo in quel caso risulta fruibile, utilizzabile, agito, non subìto.
III.1. Il film
A questo proposito mi collego al film Goodbye Lenin riassumibile nel seguente dialogo1:
– Che strano, non è cambiato niente.
– Perché, doveva cambiare qualcosa?
A parlare sono una madre, al risveglio da un coma durato otto mesi, e suo figlio Alex. La donna si è miracolosamente risvegliata a seguito di un infarto avvenuto il 7 ottobre 1989: l’ottobre dell’‘89 non è il momento migliore per cadere in coma, se si vive in Germania Est e si è orgogliosamente comunisti. Dopo il risveglio, il cuore della donna è così debole che qualsiasi shock la potrebbe uccidere, i medici consigliano di fare attenzione a situazioni emotivamente scioccanti. Per questa ragione Alex in accordo con la sorella decide di a raccontare una serie di bugie a sua madre, a mettere in piedi un sistema per non svelarle l’avvenuta caduta del Muro e l’avvento del capitalismo. Egli recupera vecchi mobili dismessi per sistemarli nella camera dove sua madre trascorrerà il suo tempo a letto, e i vecchi abiti (costringendo anche sua sorella ad indossarli); va in cerca di contenitori di cibo tedesco non più in produzione (i famosi cetrioli dell’ex DDR) nei quali trasferisce cibi di importazione; arriva anche a registrare finte edizioni del telegiornale, con i quali la madre si distrae dalla noia della convalescenza e ritarda il suo desiderio di uscire di casa.
Ciò che accade nel film è un caso – estremo – di mancata consapevolezza di un cambiamento. Lo stato di coma della donna equivale all’interruzione del tempo da lei percepito e insieme a una condizione di non cambiamento (cioè di cambiamento non consapevole): qualunque cosa sia cambiata, la donna ne è completamente all’oscuro. Ciò che suo figlio mette in atto le consente di riprendere a vivere come fosse il giorno immediatamente successivo all’infarto. Niente è cambiato, e allora il tempo non è trascorso. L’operato di Alex è paragonabile a ciò che un individuo (o il suo inconscio) mette in atto quando non vuole o non può accettare, ovvero agire, un cambiamento. Analogamente, anche il mondo esterno potrebbe agire come Alex. Che cosa farebbe pensare, a quel punto, che il tempo trascorra?
Quando torna in gioco la materia e il nostro esserne parte, non solo il mondo esterno dà al soggetto i segni del suo cambiamento (evoluzioni o involuzioni che siano), ma è il corpo stesso del soggetto a ricordargli che c’è qualcosa che subisce cambiamento, inesorabilmente. Ecco allora che il soggetto inerte soffrirà perché avvertirà una perdita di tempo, si sentirà come inghiottito da qualcosa che non riesce a vivere.
È vero che la consapevolezza della perdita di tempo è già un presupposto, l’inizio, di un cambiamento; la vera stasi avviene quando un soggetto avverte solo il fastidio, il senso di inadeguatezza, o, se vogliamo, un senso di infelicità. La stasi, o il moto, della mente e dell’animo, segnano l’inerzia, o il ritmo, del tempo vero, del tempo del cambiamento. Quante volte ci è stato raccontato di qualcuno che guardandosi allo specchio si è accorto, tutto d’un tratto, che il tempo è passato senza che se ne accorgesse?
III.2. Ancora musica
Prima di passare a Proust, in questa sezione riporto ancora versi di brani musicali che cantano il tempo, in cui si possono leggere insieme i due significati attribuiti al tempo nel Coaching. La musica, in tutti sensi, è invasa dal tempo e dalle sue diverse manifestazioni.
L’autrice, in questo brano, è Carmen Consoli:
- Nei suoi occhi il terrore costante del tempo che passa
- ed avrebbe dato qualunque cosa per un elisir
- di lunga vita
- era disperatamente sola
- alle porte dei sessanta
- …
- la mente ibernata a vent’anni
- vittima dell’inganno di questo secolo
- che rincorre il mito di forme avvenenti
- e di chirurgia estetica.
Il brano da cui è estratta la strofa è Contessa Miseria e fa riferimento all’esistenza nei nostri tempi e in particolare alla vita di una donna, la cui mente è ibernata a vent’anni e che rincorre il mito di forme avvenenti e chirurgia estetica, mentre gli occhi hanno il terrore costante del tempo che passa. Se letto da solo, il primo verso, si torna a un esempio di anti-coaching nella prima accezione di tempo considerata: il coachee legge negli occhi del Coach il terrore costante del tempo che passa, vede calpestare il proprio kairos e si sente solo a causa della mancanza di alleanza da parte del Coach.
I versi che seguono rimandano a entrambi i significati di tempo considerati in questo e nel precedente articolo. Da un lato, nei versi appare il tempo che irride il narratore, il quale si sente da esso stritolato; se al soggetto tempo, nel testo, associamo il significato di Coach, questo rappresenta un esempio di anti-coachingperché a irridere e scrutare ironicamente il narratore (coachee) è un Coach che non sa gestire il tempo e che fa sentire che il coachee è lento:
- Ora il tempo ci usura e ci stritola in ogni giorno che passa correndo,
- sembra quasi che ironico scruti e ci guardi irridendo2.
Ancora alcuni versi, che esprimono la sofferenza che porta il senso di tempo perduto, o tempo fermo:
- Ore che mai
- Trascorreranno in pace senza che
- Qualcuno le dominerà3.
E infine, due versi che, con ironia, possono essere letti come un inno alla consapevolezza e al cambiamento:
- a chi decide di ammazzare il tempo
- e il tempo invece servirebbe vivo4.
III.2. Il romanzo
Gli esempi di Coaching tratti da La strada di Swann (prima parte) sono meno immediati, poiché basati sulla lettura e interpretazione di interi pezzi dell’opera piuttosto che di singole frasi. I brani sono perciò riportati per intero, e li precede, o segue, la mia visione e interpretazione nel significato del Life Coaching. Come si potrà costatare, nella maggior parte dei casi ci si troverà di fronte ad esempi di incapacità al cambiamento, perciò di anti-coaching come l’ho definito in precedenza.
Nella parte prima de La strada di Swann il narratore (protagonista, che poi è lo stesso Marcel) descrive il villaggio di Combray5 e racconta alcuni momenti della sua infanzia. La prima scena si svolge nella camera da letto del narratore, così come egli la ricorda. In dormiveglia, descrive il suo stato mentale e diverse sue interpretazioni e visioni dell’ambiente che lo circonda.
III.3.1 Sull’immobilità e sull’abitudine di coach e coachee
Forse l’immobilità delle cose intorno a noi è loro imposta dalla nostra certezza che sono esse e non altre, dall’immobilità del nostro pensiero nei loro confronti.
Questo primo pezzo che apre il lavoro può essere visto sia dalla parte del coach che da quella del coachee. Nel primo caso, la visione immobile del coach non facilita il cambiamento del coachee; nel secondo, il cambiamento è reso difficile dall’immobilità, ovvero da convinzioni che creano le note resistenze interne.
L’abitudine! Ordinatrice abile ma assai lenta, che comincia col lasciar soffrire il nostro spirito per settimane in una istallazione provvisoria; ma che, nonostante tutto, esso è ben fortunato d’incontrare, giacché senza l’abitudine e limitato ai suoi soli mezzi sarebbe impotente a renderci abitabile una stanza. […] A Combray tutti i giorni, sul termine del pomeriggio, molto prima del momento in cui mi sarei dovuto mettere a letto e stare, senza dormire, lontano dalla mamma e dalla nonna, la mia camera ridiveniva il punto fisso e doloroso delle mie preoccupazioni. Avevano escogitato, per distrarmi nelle sere che mi vedevano un aspetto troppo infelice, di regalarmi una lanterna magica, con cui, mentre si aspettava l’ora del pranzo, coprivano la mia lampada; e, al modo dei primi architetti e maestri vetrai dell’età gotica, essa sostituiva all’opacità delle pareti impalpabili iridescenze, soprannaturali apparizioni multicolori, dov’eran dipinte leggende come in una vetrata vacillante e momentanea. Ma la mia tristezza ne veniva accresciuta, giacché anche soltanto il mutamento d’illuminazione distruggeva in me l’abitudine alla mia stanza, grazie alla quale, a parte il supplizio del coricarsi, essa mi era divenuta tollerabile. Ora non la riconoscevo più e vi ero inquieto, come in una camera d’albergo o di chalet, dove fossi giunto per la prima volta scendendo dal treno.
In questo testo si può vedere (dal mio punto di vista) da un lato la sofferenza legata all’immobilità e dall’altro l’impossibilità al cambiamento quando dettato da una imposizione: nonostante la madre e la nonna del protagonista avessero escogitato (ed imposto) l’utilizzo della lanterna magica con scopi benevoli, il protagonista non la gradisce, e preferisce piuttosto l’immobilità.
Il passo successivo, che segue immediatamente il precedente nella descrizione della lanterna magica, può essere letto in diversi modi. Ciascun personaggio della lanterna può essere visto come un coach, che per mezzo della luce passa attraverso gli oggetti senza modificarsi, come prova di centratura e di specchio (bellissimo il passo del pomo dell’uscio); viceversa, i personaggi si trasformano diventando tutti gli oggetti sui quali essi vengono proiettati (deformazione dello specchio: anti-coaching.
Al passo sobbalzante del suo cavallo, Golo, pervaso d’un atroce disegno, usciva dalla piccola foresta triangolare che vellutava d’un verde cupo il declivio d’una collina e avanzava sussultando verso il castello della povera Genoveffa di Brabante6. Quel castello era tagliato secondo una linea curva che non era se non il limite di uno degli ovali di vetro adattati nel telaio inserito tra le scanalature della lanterna. Era solo un’ala di castello e davanti c’era una landa, dove sognava Genoveffa con una cintura turchina. Il castello e la landa erano gialli e io non avevo dovuto aspettare di vederli per saperne il colore, giacché, prima dei vetri del telaio, la sonorità bruno-rossiccia del nome di Brabante me l’aveva mostrato con evidenza. Golo si fermava un minuto per ascoltare con tristezza il fervorino letto a alta voce dalla prozia […]; poi s’allontanava col solito passo sobbalzante. E nulla poteva arrestare la sua lenta cavalcata. Se si faceva muovere la lanterna, scorgevo il cavallo di Golo che continuava ad avanzare sulle tende della finestra, gonfiandosi nelle pieghe, scendendo nei solchi. Lo stesso corpo di Golo, di una essenza soprannaturale come quello della sua cavalcatura, vinceva ogni ostacolo materiale, ogni oggetto molesto che incontrava, prendendolo come ossatura e rendendolo interiore a sé, fosse stato anche il pomo dell’uscio sul quale subito s’adattava e galleggiava indomabile il suo abito rosso o la sua faccia pallida sempre egualmente nobile e malinconica, ma priva d’ogni traccia di turbamento per quella transvertebrazione.
III.3.2 Sull’immobilità e la personalità sociale
Il narratore parla di Swann, ricordando le sue visite presso la famiglia durante l’infanzia di Marcel. Swann è visto dai diversi membri della famiglia in maniera diversa, e – a eccezione della nonna – non per il nobile che è veramente, per via della sua vita mondana, delle sue frequentazioni, del suo abbigliamento. Da qui il narratore estende la sua riflessione all’immobilità di ciascuno per via dell’immobilità della visione altrui. Torna l’anti-coaching.
Ma, anche sotto l’aspetto delle cose più futili della vita, noi non siamo un tutto materialmente costituito, identico per tutti e di cui ciascuno non abbia che da andare a prender visione come d’un capitolato d’appalto o d’un testamento; la nostra personalità sociale è una creazione del pensiero altrui. Anche l’atto così semplice da noi detto “vedere una persona che conosciamo” è in parte un atto intellettuale. L’apparenza fisica dell’essere che vediamo è da noi colmata di tutte le nozioni che abbiamo su di lui, e, nell’aspetto totale che ci rappresentiamo, queste nozioni sono certo prevalenti. Esse finiscono con l’empire in modo così perfetto le gote, col seguire con una aderenza così esatta la linea del naso, s’industriano così bene di sfumare la sonorità della voce, quasi questa non fosse che un rivestimento trasparente, che, ogni volta che vediamo quel volto e sentiamo quella voce, ritroviamo e ascoltiamo quelle nozioni. […].
Il colmare l’apparenza fisica di nozioni note, fino a renderle prevalenti, fa pensare a quell’automatismo che porta in alcune circostanze a dare giudizi e interpretazioni senza avere gli elementi necesari, viceversa a colmare i vuoti in una storia che non ci viene raccontata per intero; nell’ambito del Life Coaching, l’allenamento del coach ha come obiettivo l’uscire da tale automatismo, quando affianca un coachee: nulla deve essere immaginato senza un’eventuale opportuna verifica. Nel seguito del brano riportato sotto, lo stesso narratore si rende conto della selezione che i suoi ricordi fanno quando ripensa a Swann, perché per semplicità egli lo associa ai suoi pensieri adolescenziali di quel tempo, piuttosto che a ciò che del soggetto apprende in seguito, da adulto. Ritorna perciò la resistenza, se visto dalla parte del coachee, al cambiamento, e l’immobilità, che può appartenere al coachee e che non deve invece appartenere al coach.
La veste corporea del nostro amico ne era stata così ben colmata, così come di qualche ricordo sui suoi genitori, che quello Swann era diventato un essere compiuto, vivo; e io ho l’impressione di lasciare una persona per andare verso un’altra, che ne è ben distinta, quando, nella memoria, dallo Swann che ho conosciuto con precisione più tardi torno a quel primo Swann – a quel primo Swann in cui ritrovo gli incantevoli errori della mia adolescenza che d’altronde somiglia meno all’altro che alle persone che ho conosciuto nel medesimo tempo … quasi fosse per la nostra vita come per un museo, dove tutti i ritratti della stessa epoca hanno un’aria di famiglia, una stessa tonalità, […].
III.3.3 Il risveglio e l’auto-consapevolezza
Quando dormiamo e un mal di denti non lo avvertiamo ancora se non come una ragazza che ci sforziamo duecento volte di seguito di trar fuori dall’acqua o come un verso di Molière che ci ripetiamo senza posa, è un gran sollievo svegliarsi e che l’intelligenza possa liberare l’idea del mal di denti da ogni travestimento eroico o cadenzato.
In questo pezzo, il risveglio può rappresentare non solo l’auto-consapevolezza (in questo caso di qualcosa di negativo) ma anche la presa di responsabilità da parte del coachee: egli smette di travestire il mal di denti, ovvero di attribuire qualcosa che non va come tutto dipendente completamente dall’esterno, e definisce quell’area di incidenza (il suo dente) e la sua parte di responsabilità ove cui poter eventualmente agire. L’auto-consapevolezza interrompe il sonno e cioè il tempo perso (il tempo fermo) portando auspicabilmente all’azione e al cambiamento.
Il pezzo che segue può essere interpretato in termini di Coaching in diversi modi. Nel suo insieme, può essere visto sia come crisi di autogoverno del coachee(…grave incertezza… il ricercatore è al tempo stesso [il] paese dove cercare…) che come disorientamento del coach nel suo impegno per facilitare il coachee, nel quale egli stesso è impegnato in un continuo processo di centratura di sé (il ricercatore è al tempo stesso paese dove cercare…tutto il suo bagaglio non gli servirà a nulla): il bagaglio del coach non serve a nulla, in termini di contenuto, perché ogni coachee è portatore di una storia unica e irripetibile. Entrando nei dettagli, è interessante come la ricerca di auto-consapevolezza (che io leggo nel riferimento alla verità) porta ad una creazione – che può essere vista come creazione di benessere, felicità, consapevolezza, qualunque cosa che prima si cercava e non si trovava – soltanto quando è il coachee che lavora sulla propria realtà (esso solo può rendere reale); il coach facilita questa creazione facendo luce:
Depongo la tazza e mi rivolgo al mio animo. Tocca a esso trovare la verità. Ma come? Grave incertezza, ogni qualvolta l’animo nostro si sente sorpassato da se medesimo; quando lui, il ricercatore, è al tempo stesso anche il paese tenebroso dove deve cercare e dove tutto il suo bagaglio non gli servirà a nulla. Cercare? Non soltanto: creare. Si trova di fronte a qualcosa che ancora non è, e che esso solo può rendere reale, poi far entrare nella sua luce.
III.3.4 La percezione del Tempo
Nel secondo capitolo della parte prima, il narratore torna coi ricordi ai luoghi esterni del villaggio di Combray. In particolare, interessante è il racconto delle mattine in cui soleva recarsi in chiesa con la sua famiglia:
Come l’amavo, come l’ho ancora davanti, la nostra chiesa!, alla cattedrale di Combray è dedicata una lunga descrizione che richiama esplicitamente al Tempo in un continuo passaggio dall’interno all’esterno della chiesa. In queste transizioni dall’esterno all’interno della cattedrale, Marcel descrive un passaggio temporale da una condizione di immobilità (immutabilità) dell’edificio nella sua visione intera a quella di continua mutazione in ciascun dettaglio che lo caratterizza. La percezione delle dimensioni del tempo e dello spazio vissuti nei ricordi dentro e fuori la chiesa (ovvero la chiesa nel tempo e nello spazio) riportano a un percorso di Life Coaching, non solo così come (i ricordi) sono ma anche come percezione dei tempi interni (dei cambiamenti) e dei tempi esterni (l’immutabilità dei ricordi) dell’individuo.
Il primo dettaglio di cui riporto la bellissima descrizione è quello del vecchio portico e dell’acquasantiera:
[…] deviato e profondamente incavato agli angoli (non meno dell’acquasantiera a cui ci conduceva), come se la tenue carezza dei cappotti delle contadine che entravano in chiesa e delle loro dita timide che prendevano l’acqua santa, ripetuto per secoli, avesse potuto acquistare una forza distruttiva, inflettere la pietra e intaccarla di solchi, simili ai solchi che vien formando la ruota dei carretti sui paracarri urtandovi ogni giorno.
Seguono le pietre sepolcrali addolcite dal tempo; le vetrate, nei colori e nei cambiamenti adoperati dal sole che le attraversava; gli arazzi e le figure in rilievo, che rappresentavano la verzura degli alberi, che aveva ancor vita nella parte inferiore del riquadro di seta e lana, ma s’era “estinta” nell’alto; infine, tutti quegli oggetti antichi, così preziosi che il narratore li attribuisce a personaggi leggendari che si erano recati nella chiesa, come di seguito descritto:
Tutto questo, e più ancora gli oggetti preziosi venuti alla chiesa da gente che per me eran quasi personaggi leggendari ([…]), per cui, quando ci si avviava verso i nostri posti, avanzavo in essa come in una valle visitata dalle fate, dove il contadino stupisce nel vedere in una roccia, in un albero, in uno stagno, la traccia impalpabile del loro passaggio soprannaturale, tutto questo faceva di essa per me qualcosa d’assolutamente diverso dal resto della città: un edificio che occupava, se così si può dire, uno spazio di quattro dimensioni – la quarta era quella del Tempo – che spiegava attraverso i secoli la sua nave, che, di galleria in galleria, di cappella in cappella, pareva oltrepassare e superare non pochi metri soltanto, ma epoche successive donde usciva vittoriosa: celando sotto le solide mura il rude e scabro secolo XI, di modo che questo era rivelato, con le sue céntine pesanti, chiuse e accecate da rozze pietre, soltanto dal profondo intaglio formato, presso l’atrio, dalla scalinata del campanile: e anche qui lo dissimulavano leggiadre arcate gotiche, che gli si stringevano civettuole dinanzi come le sorelle maggiori sorridendo si metto davanti, per nasconderlo ai forestieri, a un fratello più giovane, rospo, musone e mal vestito; innalzando sopra la piazza, nel cielo, la sua torre che aveva contemplato san Luigi e sembrava ancora vederlo; […].
La chiesa! Così familiare: situata nella rue Saint-Hilaire, dove s’apriva la sua porta a nord, tra la farmacia del signor Rapin e la casa della signora Loiseau, che toccava senza divisione alcuna. […] C’era tuttavia fra lei e tutto quel che non era lei un limite che il mio spirito non è mai riuscito ad oltrepassare. La signora Loiseau poteva ben avere alla sua finestra delle fresie, che prendevano la cattiva abitudine di lasciar fuggire a testa bassa da ogni parte i loro rami, e i cui fiori non trovavano nulla di meglio, quando erano abbastanza grandi, che andare a rinfrescarsi le gote violette e congestionate alla scura facciata della chiesa. Non per questo le fresie divenivano sacre per me; tra i fiori e la pietra annerita su cui s’appoggiavano, se i miei occhi non percepivano uno spazio, il mio spirito apriva un abisso.
Con le sue vetrate e i suoi arazzi, le sue consunte pietre tombali, la sua stratificazione di stili e strutture, l’interno della chiesa, gli appare come uno spazio a sé stante, dotato di una quarta dimensione, quella del tempo (nel testo con l’iniziale maiuscola): un edificio che occupava, se così si può dire, uno spazio di quattro dimensioni – la quarta era quella del Tempo, scrive Proust nel pezzo appena riportato; al contrario, l’esterno – la tozza, grossolana abside, che incarna ai suoi occhi l’archetipo della Chiesa più di ogni capolavoro dell’architettura religiosa – è ferma nei suoi ricordi in tutta la sua staticità. La frase con cui si chiude il brano precedente, e cioè la visione della vicinanza spaziale tra le fresie e il muro della chiesa e insieme dell’abisso temporale tra gli stessi – tra la chiesa e il resto del mondo – spinge il lettore assieme al narratore in una dimensione in cui il tempo non è più quello scandito dai rintocchi del campanile; si entra nel mondo interiore del narratore, come in quello di un coachee.
A conclusione di questa breve escursione tra le prime righe dell’opera Proust, mi piace riportare un pezzo nel quale il tempo descritto è un tempo buono, è untempo pieno, e perduto, in raffronto a quello esterno, solo per uno stato di totale dedizione e appagamento (un tempo di flow!):
Qualche volta anche quell’ora prematura suonava due colpi di più dell’ultima; ce n’era dunque stata una che non avevo udita, una cosa che era avvenuta non era avvenuta per me; l’interesse della lettura, magico quasi un sonno profondo, aveva ingannato i miei orecchi allucinati sopprimendo la campana d’oro sulla superficie azzurrata del silenzio.
Marcel racconta dei suoi pomeriggi d’estate trascorsi a leggere, in una condizione di coscienza in cui il tempo interiore si triplica nel moto per sorpassare la propria anima e immaginare altri mondi, nel moto della propria coscienza quando incontra i personaggi del romanzo, e infine nei moti dei sensi che colgono magnificenze del mondo esterno: il buon odore dell’aria, i fasci di luce che entrano dalle finestre, e anche: (dal)le mosche, che eseguivano davanti a me, col loro piccolo concerto, come la musica da camera dell’estate. Il protagonista descrive, in queste righe, lo stato di flow; lo stesso che vvo io nel pensare e scrivere queste pagine.
~
1 Il dialogo è alla fine della prima scena del video che sarà possibile trovare a breve nella sezione multimedia.
2 Farewell, di Francesco Guccini.
3 Fiori di lana, di Colapesce.
4 Chissà se in cielo passano gli Who, di L. Ligabue.
5 La Combray del romanzo corrisponde alla città di Illiers, dove Proust trascorre le vacanze durante la sua infanzia.